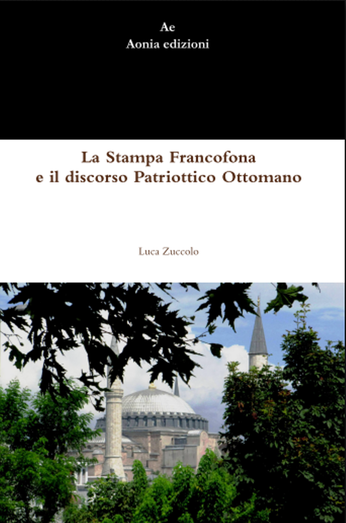“Se in Città che somiglia al clima di un Impero…”. Resti in sospeso la citazione, per un ritorno al grande interrogativo sulla più recente storia ottomana, compiuto qui analizzando i fermenti cripto-nazionalistici dall’angolatura della stampa francofona. È uno degli scopi perseguiti da Luca Zuccolo, nell’indagine condotta sull’arco di un lustro (1880-1885), intorno a due giornali, «Osmanli» e «Stamboul». Si tratta del quinquennio che vede la nascita e la fine della prima delle due testate, e insieme uno dei momenti del maggior fermento intellettuale della società, soprattutto istanbuliota, ai tempi del sultano Abdülhamid (1876-1908). La lettura di questo libro, che di una popolazione cosmopolita, (“colorata” si direbbe, piegando all’esotico) si fa osservatorio, ha stimolato in noi, tra l’altro, il ricordo di una certa presenza, tra i Deputati ottomani alle trattative della Pace di Carlowitz (1689):
“(…) Collega e compagno di Mehmed Rami Reis Efendi, capo della Delegazione, diciamo] gl’era Alessandro Maurocordato, Interprete primario della Porta, che se bene Christiano di rito Greco, è stato sollevato all’honore di Secretario, e Consigliere, et hora è stato ambasciatore; Huomo di statura più tosto grande, barba lunga, che inclina al biondo se bene incanutisse per gl’ anni, essendo di circa 60. Di carnagione bianca, pallido per accidente di malattia ultimamente sofferta, grave nel portamento, e nel motto; mà di maniere affabili, e cortesi. Parla benissimo Italiano, e Latino, fù scolaro nello studio di Padova mà bandito à causa di certo accidente, s’addottorò à Bologna in Filosofia, e Medicina; pronto di lingua e di mente (…)”.
Tale una figura, tra le moltissime, nella fitta rappresentanza imperiale, e tra i sudditi fedeli di quella potenza: affabile, quasi familiare, anche a ragione del suo soggiorno padovano, italiano. Greco, “scismatico”, nondimeno elevato a tanto rango. È verosimile che il Mavrocordato d’Imperi se ne intendesse, e che fosse incline a considerarsene erede, in una continuità più o meno sotterranea, sì, ma certamente d’impronta territoriale e mentale. Così ebbe a funzionare uno Stato, chiamato “barbaro” quando conveniva demolirne l’immagine, e ritenuto temibile, ma insieme degno, legittimo, sempre, a Venezia e altrove: nelle cangianze dei tempi e dei pensieri, degli interessi. Teniamo davanti agli occhi quella figura, quell’emblema, e passiamo ad altre raffigurazioni.
Al tramonto di quella potenza, le idee su di esso, e da esso, si irradiavano comunque, e fervide, per coaugularsi intorno a nuclei diversificati, fin divergenti, e riflettersi nelle lettere, nei caratteri, nei tipi, delle tipografie. La stampa periodica non è che uno strumento, una faccia impressa dalle ideologie lanciate nell’arena, interna, interiore (nel verso anche delle coscienze), ed esterna, degli scontri e delle soluzioni alternative alla crisi di quella statualità. Non stupisce che storicamente - in un dato periodo storico, estremo segmento che fornisce una continuità a quello che ha visto Alessandro Mavrocordato e i suoi concittadini in azione, in missione “imperiale” - a schierarsi nel campo filo-Abdülhamid siano stati anche i sudditi non musulmani, non turchi, e i fondatori, i collaboratori di giornali, riviste, fogli diversamente portatori di retoriche di regime. Talché, viene a delinearsi perlomeno un poligono, specialmente un triangolo, con ai vertici l’Impero e la dinastia, la Grecità (più che la Grecia), e la Francia. Si danno le intese, e i malintesi. Secoli di alleanze franco-turche non escludono le censure dell’assolutismo, le interferenze. Ma i sudditi greci d’Istanbul, un nome che vuol dire Polis, per antonomasia, possono ben sentirsi, in modo nitido ma soggetto a mutazioni, i prosecutori di una successione imperiale elleno-ottomana. Sono le voci di coscienze devolute al servizio di una sovranità quasi emanata dagli avi dominanti a Costantinopoli, ripresa da Istanbul, sempre dalla Polis, cioè. E negli anni successivi alle Riforme (Tanzimat, 1839-1876) è erroneo, superficiale, arrogante, eurocentrico, trattare quei governanti alla stregua di malleabili persone esposte alle istruzioni di Inghilterra e Francia. Ma il Patriarcato greco-ortodossso si opponeva reattivo alle istanze nazionalistiche dei Bulgari, che pure riusciranno a strappare un esarcato, nel 1871. Nondimeno, con il francese, e con il greco, di pari passo procedeva il turco: reso man mano capace di recepire, rielaborare, respingere i concetti dei “Franchi”; o di imprimere toni e sfumature di una ricerca di “identità” al dire francese. All’esotizzazione del “Turco” si imprime una piega specifica, ottomana, certo impressa da dizioni politiche francesi; del resto, l’Impero rientrava per forza e cultura nei confini dei “Franchi”. Rientra nell’armamentario di Occidente e di Oriente l’impiego del marchio del “dispotismo”, tradotto in turco con istibdâd, parola che in terimini islamici significherebbe “buon governo”, giusto, retto.
Epoca di altri simboli, di contorsioni semantiche, le quali racchiudono in sé i nuclei delle profonde, buie domande sulla identità, confusi nella storia e nei suoi tornanti, e nella immaginazione di una comunità nazionale ottomana, connotata però vieppiù dai tratti turchi, ora ricalcati su quelli sottolineati negli Occidenti, ora da quelli ben differenziati, in via di opposizione. La stampa, le scuole, l’esercito, le cerimonie, le festività risuonano di queste note, propagandistiche: a far rivivere l’autorità sovrana, risacralizzata, e quella burocratica: ranghi, uffici, funzioni, doveri, allineati su un patriottismo che è promessa di salvezza per tutti, con il tutto che si staglia dai caratteri a stampa, latini o arabi; strumenti articolati in grado di provocare forti risonanze.
Sultano-Padre, di tutti i sudditi, quasi annuncio di nuova paternità, quali il gran condottiero Mustafa Kemal, l’Atatürk, altro Padre, all’orizzonte, sempre ampio, ma a grado a grado limitato alla vocazione dei Turchi, con l’omissione di altre presenze, vieppiù sgradite, date le loro tendenze alla emancipazione, travolte poi dalla pratica delle stesse teorie nazionalizzanti europee, o dall’islamismo preponderante. Né, da quell’orizzonte limitato, visto ex post e da Ovest, potrà esulare l’orientalizzazione della visione del Paese: anche questo aspetto interviene a dar corpo al ritratto di una identità fatta di tesserine e frammenti, schegge centrifughe per un istante bloccate dal richiamo alla lealtà al Signore, allo Stato. Con l’Ottomanesimo che, tingendosi sempre più di islam politico, si rivela come alta Missione, tesa alla integrazione terrena e perenne dei sudditi.
“(…) Collega e compagno di Mehmed Rami Reis Efendi, capo della Delegazione, diciamo] gl’era Alessandro Maurocordato, Interprete primario della Porta, che se bene Christiano di rito Greco, è stato sollevato all’honore di Secretario, e Consigliere, et hora è stato ambasciatore; Huomo di statura più tosto grande, barba lunga, che inclina al biondo se bene incanutisse per gl’ anni, essendo di circa 60. Di carnagione bianca, pallido per accidente di malattia ultimamente sofferta, grave nel portamento, e nel motto; mà di maniere affabili, e cortesi. Parla benissimo Italiano, e Latino, fù scolaro nello studio di Padova mà bandito à causa di certo accidente, s’addottorò à Bologna in Filosofia, e Medicina; pronto di lingua e di mente (…)”.
Tale una figura, tra le moltissime, nella fitta rappresentanza imperiale, e tra i sudditi fedeli di quella potenza: affabile, quasi familiare, anche a ragione del suo soggiorno padovano, italiano. Greco, “scismatico”, nondimeno elevato a tanto rango. È verosimile che il Mavrocordato d’Imperi se ne intendesse, e che fosse incline a considerarsene erede, in una continuità più o meno sotterranea, sì, ma certamente d’impronta territoriale e mentale. Così ebbe a funzionare uno Stato, chiamato “barbaro” quando conveniva demolirne l’immagine, e ritenuto temibile, ma insieme degno, legittimo, sempre, a Venezia e altrove: nelle cangianze dei tempi e dei pensieri, degli interessi. Teniamo davanti agli occhi quella figura, quell’emblema, e passiamo ad altre raffigurazioni.
Al tramonto di quella potenza, le idee su di esso, e da esso, si irradiavano comunque, e fervide, per coaugularsi intorno a nuclei diversificati, fin divergenti, e riflettersi nelle lettere, nei caratteri, nei tipi, delle tipografie. La stampa periodica non è che uno strumento, una faccia impressa dalle ideologie lanciate nell’arena, interna, interiore (nel verso anche delle coscienze), ed esterna, degli scontri e delle soluzioni alternative alla crisi di quella statualità. Non stupisce che storicamente - in un dato periodo storico, estremo segmento che fornisce una continuità a quello che ha visto Alessandro Mavrocordato e i suoi concittadini in azione, in missione “imperiale” - a schierarsi nel campo filo-Abdülhamid siano stati anche i sudditi non musulmani, non turchi, e i fondatori, i collaboratori di giornali, riviste, fogli diversamente portatori di retoriche di regime. Talché, viene a delinearsi perlomeno un poligono, specialmente un triangolo, con ai vertici l’Impero e la dinastia, la Grecità (più che la Grecia), e la Francia. Si danno le intese, e i malintesi. Secoli di alleanze franco-turche non escludono le censure dell’assolutismo, le interferenze. Ma i sudditi greci d’Istanbul, un nome che vuol dire Polis, per antonomasia, possono ben sentirsi, in modo nitido ma soggetto a mutazioni, i prosecutori di una successione imperiale elleno-ottomana. Sono le voci di coscienze devolute al servizio di una sovranità quasi emanata dagli avi dominanti a Costantinopoli, ripresa da Istanbul, sempre dalla Polis, cioè. E negli anni successivi alle Riforme (Tanzimat, 1839-1876) è erroneo, superficiale, arrogante, eurocentrico, trattare quei governanti alla stregua di malleabili persone esposte alle istruzioni di Inghilterra e Francia. Ma il Patriarcato greco-ortodossso si opponeva reattivo alle istanze nazionalistiche dei Bulgari, che pure riusciranno a strappare un esarcato, nel 1871. Nondimeno, con il francese, e con il greco, di pari passo procedeva il turco: reso man mano capace di recepire, rielaborare, respingere i concetti dei “Franchi”; o di imprimere toni e sfumature di una ricerca di “identità” al dire francese. All’esotizzazione del “Turco” si imprime una piega specifica, ottomana, certo impressa da dizioni politiche francesi; del resto, l’Impero rientrava per forza e cultura nei confini dei “Franchi”. Rientra nell’armamentario di Occidente e di Oriente l’impiego del marchio del “dispotismo”, tradotto in turco con istibdâd, parola che in terimini islamici significherebbe “buon governo”, giusto, retto.
Epoca di altri simboli, di contorsioni semantiche, le quali racchiudono in sé i nuclei delle profonde, buie domande sulla identità, confusi nella storia e nei suoi tornanti, e nella immaginazione di una comunità nazionale ottomana, connotata però vieppiù dai tratti turchi, ora ricalcati su quelli sottolineati negli Occidenti, ora da quelli ben differenziati, in via di opposizione. La stampa, le scuole, l’esercito, le cerimonie, le festività risuonano di queste note, propagandistiche: a far rivivere l’autorità sovrana, risacralizzata, e quella burocratica: ranghi, uffici, funzioni, doveri, allineati su un patriottismo che è promessa di salvezza per tutti, con il tutto che si staglia dai caratteri a stampa, latini o arabi; strumenti articolati in grado di provocare forti risonanze.
Sultano-Padre, di tutti i sudditi, quasi annuncio di nuova paternità, quali il gran condottiero Mustafa Kemal, l’Atatürk, altro Padre, all’orizzonte, sempre ampio, ma a grado a grado limitato alla vocazione dei Turchi, con l’omissione di altre presenze, vieppiù sgradite, date le loro tendenze alla emancipazione, travolte poi dalla pratica delle stesse teorie nazionalizzanti europee, o dall’islamismo preponderante. Né, da quell’orizzonte limitato, visto ex post e da Ovest, potrà esulare l’orientalizzazione della visione del Paese: anche questo aspetto interviene a dar corpo al ritratto di una identità fatta di tesserine e frammenti, schegge centrifughe per un istante bloccate dal richiamo alla lealtà al Signore, allo Stato. Con l’Ottomanesimo che, tingendosi sempre più di islam politico, si rivela come alta Missione, tesa alla integrazione terrena e perenne dei sudditi.
Tuttavia, ci si rispecchia, certo deformandosi, negli altri, nelle tradizioni ritrovate, cioè reinventate. Per immedesimarsi, imitare o respingere, cancellare. Nell’illusione di un riconoscersi, di un identificarsi, si recitano concezioni della terra turca, ricalcate magari su quella francese, con le ricadute nelle tracce della modernità d’altrove, ma non estranea, in una consuetudine (qui si sente la lezione di J. Michelet, a sua volta debitore al pensiero germanico):
Tu una sera di sogno eri venuta a contemplare
Su ogni colle del paese cui tu tanto somigli.
Parlavi e ti guardai: sempre più eri bella,
Sempre più nella tua voce io sentivo Istanbul.
Su questo tuo paese la tua stirpe ti plasmava
E scorrevano le insegne a sfidare gli orizzonti,
A che in volto riflettessi la tua storia,
Oh, quant'oro sanguigno di campioni nel marmo si impastò.
Ora, tal plasmarsi su questo “tuo Paese” varrebbe per tutti quelli che lo abitano, da molto prima dei Turchi, i quali qui da un millennio in ogni caso ci sono. Ma l’impasto sembra di una pasta diversa, estranea a contaminazioni. Visioni, e immedesimazioni, con i rigetti della Francia, dove pur ci si è nutriti di Oriente. Infatti, con Yahya Kemal (1884-1958) si assiste all’invenzione di una classicità massiccia (fatta dall’intera storia poetica ottomana, senza analisi, distinzioni in periodi), alla quale rifarsi per ristabilire quel rapporto diretto con la tradizione interrotto dalle Tanzimat. Ma si tratta appunto di stupenda invenzione, maturata durante il soggiorno francese di Yahya (1903-1912), mediante le letture di Le conte de Lisle, Heredia, Moréas, Baudelaire, i saggi di Jules Michelet, l’insegnamento di Calille Jullian, e lo studio dei canzonieri ottomani e persiani custoditi alla Bibliothèque Nazionale. Adesso, abbia fine quella sospensione iniziale, restituiamo il verso alla strofa, che è giro di pensieri:
(…) Se in Città che somiglia al clima di un Impero,
In notti immense pari all'illusione,
Là, rimpetto alle stelle,
Se insieme con l'amica
Iddio mi elargisse la salute di brindare...
Basterebbe!
Basterebbe davvero? Allora, vuol dire che la Città, la Polis, gradualmente era uscita di sé in cerca di se stessa, per restare solo a “somigliare al clima di un Impero”. Parvenze, fantasmi, abbagli, riflessi dalla stampa, che il libro di Zuccolo è attento a raccogliere.
Tu una sera di sogno eri venuta a contemplare
Su ogni colle del paese cui tu tanto somigli.
Parlavi e ti guardai: sempre più eri bella,
Sempre più nella tua voce io sentivo Istanbul.
Su questo tuo paese la tua stirpe ti plasmava
E scorrevano le insegne a sfidare gli orizzonti,
A che in volto riflettessi la tua storia,
Oh, quant'oro sanguigno di campioni nel marmo si impastò.
Ora, tal plasmarsi su questo “tuo Paese” varrebbe per tutti quelli che lo abitano, da molto prima dei Turchi, i quali qui da un millennio in ogni caso ci sono. Ma l’impasto sembra di una pasta diversa, estranea a contaminazioni. Visioni, e immedesimazioni, con i rigetti della Francia, dove pur ci si è nutriti di Oriente. Infatti, con Yahya Kemal (1884-1958) si assiste all’invenzione di una classicità massiccia (fatta dall’intera storia poetica ottomana, senza analisi, distinzioni in periodi), alla quale rifarsi per ristabilire quel rapporto diretto con la tradizione interrotto dalle Tanzimat. Ma si tratta appunto di stupenda invenzione, maturata durante il soggiorno francese di Yahya (1903-1912), mediante le letture di Le conte de Lisle, Heredia, Moréas, Baudelaire, i saggi di Jules Michelet, l’insegnamento di Calille Jullian, e lo studio dei canzonieri ottomani e persiani custoditi alla Bibliothèque Nazionale. Adesso, abbia fine quella sospensione iniziale, restituiamo il verso alla strofa, che è giro di pensieri:
(…) Se in Città che somiglia al clima di un Impero,
In notti immense pari all'illusione,
Là, rimpetto alle stelle,
Se insieme con l'amica
Iddio mi elargisse la salute di brindare...
Basterebbe!
Basterebbe davvero? Allora, vuol dire che la Città, la Polis, gradualmente era uscita di sé in cerca di se stessa, per restare solo a “somigliare al clima di un Impero”. Parvenze, fantasmi, abbagli, riflessi dalla stampa, che il libro di Zuccolo è attento a raccogliere.